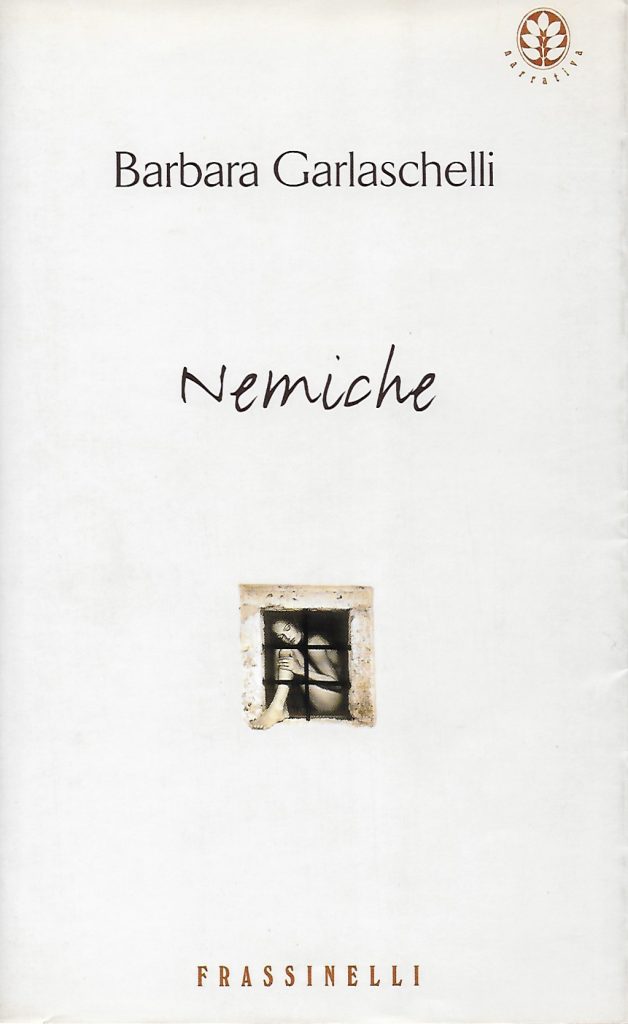
La clausura
Sono tornata.
Il mio viaggio è stato lungo, strano, luminoso a tratti.
Un viaggio che non volevo fare ma in cui ho imparato molte cose, come capita spesso durante i viaggi.
Non ho ricordi di immagini o pensieri, ma di una specie di dondolio che, di tanto in tanto, si trasformava in un beccheggio folle, un su e giù in cui ho temuto di perdermi.
Non riesco a uscire da questa gabbia trasparente in cui pensare è difficile come infilare perline di vetro in una notte senza luna.
Ho viaggiato a lungo senza spostarmi da qua.
E ora sono tornata.
Ma nessuno se n’è accorto.
È il bianco.
Tutto questo bianco.
I soffitti, le pareti, le lenzuola, i camici.
Il bianco e l’acciaio; sembra non esistere nient’altro, come se il mondo avesse perso forme e colori.
E l’odore.
Un odore di etere, alcol e dolore. Dolore che si è depositato in questa camera giorno dopo giorno, che ha impregnato i letti, le sedie, i cuscini, i materassi e che nessun disinfettante riuscirà mai a cancellare.
Poi il caldo e il silenzio. Come essere ritornata nell’utero di mia madre.
Un utero affollato, per la verità; gente che entra e esce cercando di non fare rumore. Mi guardano, schiacciano dei bottoni, controllano il mio corpo, m’infilano aghi nelle braccia, mi lavano.
Prima era sempre silenzio, ora è sempre musica.
La mattina in cui ho cominciato a percepire le note accarezzarmi il cervello avrei voluto sorridere. Note dolci, melense.
Mia sorella Alice è entrata nella stanza e ho ascoltato le sue parole appena sussurrate esplodermi nei timpani.
«Non uscirà mai dal coma con questa cazzo di musica. Melissa odia la musica classica. Non avete qualcosa di più… coraggioso?»
Tipico suo esprimersi in questo modo. Avrei voluto baciarla e chiederle dov’era stata tutto questo tempo. Avrei voluto alzarmi e alzare il volume delle musica e farmi travolgere dalla melodia. Non m’importava che fosse classica o jazz o pop. M’importava che riuscivo a sentirla.
Come riuscivo a sentire la voce rauca di Alice.
«Che cosa dobbiamo mettere, rock duro?» Non sapevo chi aveva parlato ma capivo che era qualcuno che non sopportava Alice. E doveva essere un rancore di vecchia data, lo intuivo dalla stanchezza con cui quel qualcuno aveva pronunciato le parole, come di chi è stanco di combattere ma non può farne a meno.
«È da due anni che vi ripeto sempre la stessa solfa, cos’è lo fate apposta?»
Due anni?
Era durato così tanto, dunque, il mio viaggio?
Ho la sensazione di tornare a rate: prima l’udito, poi la vista, poi l’olfatto.
Sto riconquistando il mondo, ma pare che il mondo non riconquisti me.
Nessuno, nessuno si rende conto che io sono qui, vigile.
Si preoccupano del mio corpo, l’unica parte di me a non essere tornata. O meglio, so che c’è ma è come se non mi appartenesse.
Ogni tanto vedo qualcuno che mi solleva una gamba, scorgo il bianco dei piedi, la collinetta ossuta della rotula ma è come se fosse di qualcun altro.
Anche le mani mi sembra che appartengano a un essere che non conosco e quando mi capita di intravederle mentre la fisioterapista le muove e le porta proprio davanti al mio viso, ne resto affascinata. Non ricordavo di avere dita così lunghe e affusolate.
Com’è è possibile essere qui eppure non esserci?
Vorrei risentire il mio corpo.
Vorrei percepire le mani di mia sorella che mi massaggiano le spalle con delicatezza, o il fresco della spugna che l’infermiera mi passa sulle braccia, o le labbra di mio padre che mi sfiorano la guancia. E poi il solletico dei capelli sul collo.
E a volte vorrei urlare.
E ridere.
E piangere.
E parlare.
E gridare: «Liberatemi da questa prigione».
«Melissa, oggi è il tre luglio. Ti ricordi? È stato quando papà ci ha portate in aereo a Parigi per la prima volta e tu hai vomitato per tutto il viaggio. Gesù, sei sempre stata un tale disastro! Cavoli, te la ricordi Parigi? Sì che te la ricordi, dicevi sempre che avresti voluto andarci a vivere…»
Certo che mi ricordo Parigi. Ci ho messo tanto a recuperare la sua immagine ma, alla fine, ce l’ho fatta. E’ strano, è come se la mia mente fosse un baule profondo in cui affondo le mani per afferrare pensieri, ricordi, visioni.
Parigi si staglia nitida nel mio cervello, così come si staglia nitido quel viaggio terrificante, sospesi lassù, nel vuoto, in una bara di metallo con le ali…
«Ti ricordi quando camminavamo lungo la Rive Gauche e battevamo i denti dal freddo e ci siamo rifugiati a Notre Dame per riscaldarci?»
Pagherei qualunque cifra per sentire ancora quel vento gelido che pareva tagliare i vestiti e mordere la carne.
«Signorina, dobbiamo fare i prelievi. Dovrebbe uscire un momento.»
No, non te ne andare Alice, non lasciarmi adesso, parlami ancora di Parigi.
«D’accordo. Melissa, tesoro, torno subito, ok?»
Non aspetta una risposta.
La vedo alzarsi e ricacciare un ciuffo ribelle dentro la cuffia bianca. Solo ora mi accorgo di quanto sia cambiato il suo viso, quanto sia cresciuta. La sua vita ha continuato ad avanzare mentre la mia si è sospesa in una bolla di niente.
Come sarà la mia faccia?
Chissà, forse se potessi vedermi mi parrebbe quella di un’altra, proprio come succede con le mie mani.
Due anni.
Due ere.
«Passami la siringa. Io mi chiedo come fanno a non impazzire. Due anni trascorsi a parlare a una persona che ami ma che non riesce neanche a sentirti.»
«Forse ti sente, invece…»
«Sì? Secondo te quella è la faccia di una che ti sente?»
«Nessuno può sapere. La famiglia non ha voluto scollegarla dalle macchine…»
«Lo so, lo so. Le conosco anch’io queste stronzate. Fatto sta che questa poveretta è in un altro universo e né sua sorella né suo padre e nemmeno Gesù Cristo ci arriveranno mai.»
«Piantala con questi discorsi.»
«Merda, a volte mi pare di impazzire. Mi sembra che non serva a niente quello che facciamo. Tieni, buttala nel cestino.»
«Melissa, è successo un casino! Perché non puoi aiutarmi!»
È disperante questa situazione. Riuscissi a battere almeno una ciglia, un mignolo, un orecchio. Sentire che parlano di me come se fossi su Marte, sentire il mondo entrare da quella porta per alcune ore e non riuscire nemmeno a sfiorarlo.
«Lo ha ammazzato, capisci? Certo, non voleva, ma gli ha dato una botta in testa così forte…»
Chi ha ammazzato chi?
Forse non è vero che sono tornata. Forse sto ancora aggirandomi nel mio universo fatto di luce e immagini strappate.
«Sabino è un tale stronzo ma un tale stronzo! Forse te lo ricordi, frequentavate la stessa scuola, solo che lui era un anno avanti. Mi pare fosse nella sezione A…»
Quello! Non me lo dire, piccola Alice, che hai perso la testa per un bulletto da quattro soldi che si muoveva sinuoso come una serpe…
«È una carogna, prepotente, saccente e insopportabile…»
Bene così…
«… ma quando mi tocca, gesù Melissa, mi sembra di venire proiettata in un’altra dimensione…»
Ed è lì che vorrei tornare perché so che adesso mi racconterai qualcosa che non voglio sentire. Ti prego ti prego ti prego…
«Sai come succede, vero?»
Sì, che lo so: una mano ti sfiora e tu voli. Una bocca ti bacia e tu pensi che tutto sarà perfetto.
«Io devo parlarne con qualcuno Melissa, o muoio. Io l’ho visto Sabino mentre spaccava la testa a quel tipo. Non so, credo abbiano litigato per soldi. Quel tizio ha cominciato a spintonarlo, gli ha mollato un pugno e Sabino ha afferrato un pezzo di legno lì per terra e lo ha colpito una due tre quattro volte. Oh Melissa, è stato terribile…»
Piccola Alice, sei sempre stata così brava a infilarti in queste storie assurde mentre io cercavo di tenertene fuori. Mi illudevo di difenderti dal mondo e anche mamma e papà s’illudevano e tu, invece, sempre a testa bassa contro tutto. Sempre dentro fino al collo nella vita.
«Ma sai qual è la cosa peggiore?»
C’è ancora qualcosa di peggiore?
«Sabino mi ha vista. Ha detto che se apro bocca mi strangola con le sue mani. E quello lo fa di sicuro. Quel bastardo figlio di puttana!»
Vedo la porta che si apre.
«Signorina, abbassi la voce. Questa è una camera di rianimazione non il mercato.»
«Mi scusi…»
La porta si richiude.
«Stronza.»
Vedo che mi passa una spugna sulla fronte e guarda nel vuoto. Parla ma non a me.
«Pensavo mi amasse…»
Come sempre…
Non posso salvarti dal mondo questa volta.
Scorgo il suo viso appeso sopra il mio come una piccola luna pallida e i suoi occhi neri si posano sui miei. E il suo sguardo è duro.
«Melissa, perché non mi parli?»
Mi scruta alcuni secondi e io vorrei accarezzarla e abbracciarla come facevo quand’era bambina e difenderla dal mondo mi sembrava ancora possibile.
Le sue labbra si avvicinano alla mia guancia e la sfiorano.
E io non so se le sento davvero o lo desidero soltanto.
Ora è sempre musica classica.
Non riesco a concentrarmi, pensare, trovare una soluzione, un senso.
Gli infermieri e i dottori mi curano, mi tastano, mi voltano e rivoltano; mio padre e mia madre mi accudiscono, mi accarezzano; le macchine controllano il mio cuore, le mie pulsazioni, il mio cervello.
Tutto sembra continuare come sempre, solo che mio padre non riesce a parlarmi e mia madre s’interrompe ogni tanto e fa sospiri lunghi, come se dovesse cacciare giù con forza qualcosa che le sta chiudendo la gola.
Nessuno mi parla di Alice.
©Barbara Garlaschelli, Frassinelli, 1997