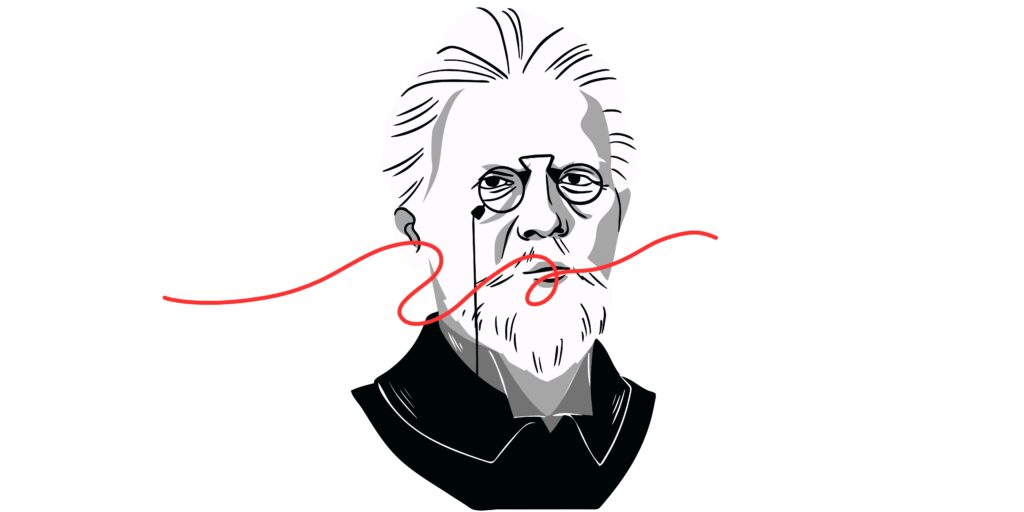
La storia di Cechov inizia da una «speciale provvidenza», un colpo di tosse nel 1884, forse venuto dall’alto, come quel suono misterioso e triste che attraversa il giardino dei ciliegi, un suono doloroso che è compiuta forma dei propositi cechoviani. Siamo nella primavera del 1884. Università di Mosca. Il giovane Anton sta per discutere la sua tesi di laurea in medicina. Un colpo di tosse improvviso. Violento.
Poi un altro, e un altro ancora. Una incontenibile serie di colpi di tosse. Anton beve un bicchiere d’acqua, ma la tosse continua, sempre più violenta. Allora Anton si porta un fazzoletto davanti alla bocca, tossisce ancora e ancora e ancora. Poi sente un dolore lancinante al petto. Quando toglie il fazzoletto dalle labbra, vede una macchia rossa di sangue, come un’isola di dolore su un mare candido. Il Dottor Cechov osserva il proprio sangue senza stupore, come un medico al cospetto del paziente, e una parola attraversa la sua mente: tisi. Una parola che fino ad allora aveva letto soltanto nei manuali, in quel momento si stampa indelebilmente nel suo cuore, così come il male si insinua irreversibilmente nei suoi polmoni. Anton Pavlovic non sa ancora quando sarà, ma è consapevole che la sua fine prematura è inevitabile.
Da quel momento il tempo è «fuori di squadra».
A soli ventiquattro anni, Cechov capisce che non c’è più molto tempo. E non ha ancora scritto una sola parola di quelle che noi amiamo e abbiamo letto e riletto infinite volte. La morte s’insinua all’interno della vita, e non semplicemente come suo avversario, ma come l’origine cui essa tende – rispetto a cui la vita è solo una deviazione, un turbamento momentaneo – e che continuamente la accompagna con la sua presenza silenziosa. È soltanto una questione di tempo. Un attimo fuggente nel flusso del divenire. Durante gli accessi di tosse «si svuotava come una bottiglia capovolta, messa in verticale», racconta Gorkij. In pochi anni sarà costretto a portare a tracolla, sull’anca sotto la giacca, una borraccia di pelle, e quando avrà un accesso di tosse, sputerà nella borraccia un espettorato rossastro, ma non perderà mai il suo gustoso umorismo. Sentite cosa dice della sua difficile situazione: «vivere per morire non è in generale divertente, ma vivere sapendo che si morrà prima del tempo è addirittura stupido.» Non dovete dimenticare che Cechov è prima di tutto un umorista.
Ancora studente universitario, egli entra nel mondo della letteratura scrivendo brevi racconti (non più di cento righe) per settimanali satirici. Anton Pavlovic scrive per un unico motivo: soldi, pochi ma buoni, e strettamente necessari per uno studente di medicina, il cui padre aveva dichiarato fallimento e viveva sulle spalle dei figli. Il giovane Cechov, autore di questi primi racconti, per pudore o vergogna, non si firma con il proprio nome, cognome e patronimico, ma inventa uno pseudonimo, un altro sé stesso: Antosha Cechonté.
Tutte le pièce che Cechov scriverà negli anni della maturità artistica avranno un impianto comico e mi piace pensare che Il gabbiano, Zio Vanja, Tre sorelle, Il giardino dei ciliegi siano pièce scritte a quattro mani, da Anton Pavlovic Cechov da Antosha Cechonté. Quella fantasmatica figura, infatti, non è svanita negli anni Ottanta della giovinezza, ma ha sempre accompagnato Anton Pavlovic come un doppelganger chiassoso e burlone, felice di aver ottenuto un po’ di spazio in più rispetto alle abituali cento righe con cui le redazioni limitavano il suo estro creativo. Il gabbiano, Zio Vanja, Tre sorelle, Il giardino dei ciliegi sono il frutto dell’umorismo di Antosha e dell’acume del dottor Cechov: mentre Antosha ci fa ridere, Anton Pavlovic ausculta il polso di un mondo moribondo, che muore con gioia e spensieratezza e coraggio. Il dottor Cechov accerta la malattia, Antosha Cechonté ne descrive l’agonia, con gli inevitabili lazzi del commediante e tra «le risa, gli scherzi, gli sprazzi d’allegria», si sente il suono della corda che si spezza.
Da quest’antinomia tra ciò che sembra comico da un lato, ma tragico se visto da un altro lato, Cechov ha costruito l’anamorfosi di un teatro unico e mai vi sarebbe riuscito senza la complicità del giovane e spensierato Antosha Cechonté, un ragazzo che non sapeva ancora di dover morire…
Quando leggete Il gabbiano o lo Zio Vanja, ma soprattutto Tre sorelle e Il giardino dei ciliegi, scritti quando le condizioni di salute si stavano aggravando irrimediabilmente, vi rendete conto che tra le parole, tra le pieghe del tempo, nella voce di Cechov, si insinua silenziosa la morte, il sentimento della fine. Il suo teatro è il lungo pensiero covato di un mortale che tiene d’occhio la propria morte, la tiene d’occhio in ogni colpo di tosse, in ogni macchia di sangue sul fazzoletto, in ogni singola frase, parola, sillaba strappata all’oblio e resa immortale.
©Matteo Tarasco