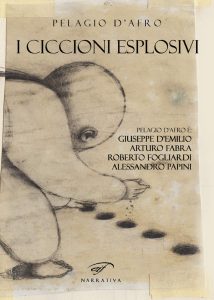Ma fu dopo la curva che lo vide.
Non si aspettava che il castello apparisse dalla strada così presto. Il tempo e le distanze, si sa, sono fattori variabili con l’età; quando si è piccoli, tutto è più, rispetto alla realtà: più grande, più bello, più lontano…
Nel castello ci andava a giocare, da piccolo: Indiani, Zorro, cose così. Alle principesse e ai cavalieri non ci pensava, allora. Quelle antiche mura, le torri diroccate e il prato tutto intorno, furono per anni il teatro della sua fantasia. E per tutta la vita, per tutti quegli anni passati altrove, ogni castello che avesse incontrato in fiabe e romanzi sarebbe stato quel castello. Il castello di Popoli: ’u castioj’, nel locale dialetto abruzzese.
L’antica fortezza era un po’ diversa da come la ricordava o, forse, da come la memoria l’aveva resa favolosa nel corso di sessantatré anni di lontananza. Chissà, magari l’avevano restaurata. Sulla torre più alta vedeva ora sventolare bandiere multicolori, e poteva giurarlo che una volta non c’erano.
Del resto, era stato via per più di mezzo secolo, dall’altra parte del mondo.
Parcheggiata l’auto a noleggio, si rese conto che il suo paese natale era davvero cambiato, ma era sicuro che il centro storico non poteva essere mutato di molto. E fu così che si ritrovò presto a passeggiare per la parte alta del paese.
I pochi giovani che ancora vi abitavano lo guardavano con indifferenza, quasi che fosse normale che uno straniero, perché tale ormai era, percorresse a piedi con passo lento quelle antiche vie quasi deserte. La maggior parte degli abitanti doveva essersi trasferita nella parte bassa, più accessibile, più comoda, più moderna, proiettata verso i grandi centri commerciali della costa. Fu negli occhi degli anziani seduti, proprio come una volta, sull’uscio di casa, che ritrovò l’antica soggezione verso il forestiero, e le domande senza risposte della gente senza patente: chissà perché è venuto proprio da noi?
Ogni pietra, ogni vicolo, ogni androne si rivelavano, folgoranti, come lo scenario dei sogni e dei desideri di una vita. Ricordi nitidi, stavolta, non inquinati dal tempo.
Lì, tremante, aveva dato la mano alla figlia di emigranti in Belgio tornati d’estate al paese – millantando invidiabile benessere – e di nascosto l’aveva baciata su una guancia. Dietro quel portone marrone scuro dovevano esserci ancora i fantasmi (lo dicevano i vecchi che c’erano, e tutti credevano ai vecchi). Su quel marciapiede, nell’angolo, il venditore ambulante di latte, la sera, appoggiava il suo bidone per poi mettersi a chiamare le donne. In quella casa, ora tutta scrostata e abbandonata, aveva visto per la prima volta una donna morta, con il Rosario tra le mani giunte a forza.
Sulla discesa che portava in piazza un giorno era caduto: correva per rientrare a casa, era tardi e aveva paura dei rimproveri; così era inciampato, sbucciandosi un ginocchio e ancora ne portava i segni, dopo più di mezzo secolo. E proprio appena prima della piazza, un giorno, aveva accarezzato il cane che non si poteva toccare; non era di nessuno, ma era di tutti; le donne gli davano da mangiare, ma sgridavano i bambini che volevano giocare con lui, perché dicevano che aveva la rogna e le pulci.
In quella casa rosa abitava la ragazza che si era suicidata gettandosi nel fiume per amore.
Laggiù, barcollante, passava tutte le sere, cantando, l’ubriacone. Lassù, misteriosa, bellissima e inavvicinabile, viveva la puttana.
Prese la salita, rendendosi conto di averla imboccata con sicurezza, come faceva da bambino, come se sessantatré anni non fossero mai passati.
Attraversato il bosco, giunse infine al castello e si stese sotto un altissimo abete, gustandosi l’odore di resina e il silenzio amplificato dal vento leggero della fresca valle sottostante. Chiuse gli occhi con una strana pace nell’animo.
Il vento.
D’un tratto, come se si trovasse sotto il Ficus Religiosa del Buddha, comprese che quell’ansia sottile e penetrante che l’aveva sempre accompagnato nella sua vita di emigrante non era dovuta alle preoccupazioni, al lavoro, agli impegni.
La realtà era che non era mai stato a casa. Non era mai restato, non era mai tornato. Aveva vissuto nel mondo, nell’altra faccia del mondo. Ma il mondo non era mai stato casa.
Aprì gli occhi ancora per un istante, rimase abbagliato dalla luce che pure volgeva al crepuscolo. Il cielo, da azzurro che era stato nel pomeriggio, stava virando al rosa.
Forse doveva decidersi a tornare indietro, prima del buio.
Ancora un po’, si disse. Non è ancora tardi.
©Giuseppe D’Emilio

Giuseppe D’Emilio vive e lavora nelle Marche; è membro del laboratorio creativo Carboneria Letteraria ed è uno dei quattro componenti dello scrittore collettivo Pelagio D’Afro . Questo racconto è uno dei suoi pochi lavori da solista.
Fra le sue ultime pubblicazioni, l’antologia Alla periferia della galassia stanca, della Carboneria Letteraria a cura di Pelagio D’Afro & Biancastella Lodi, Edizioni Homo Scrivens, 2017 e la ristampa de I ciccioni esplosivi, Pelagio D’Afro, Edizioni Il Foglio 2019, con prefazione di Alessandro Morbidelli.